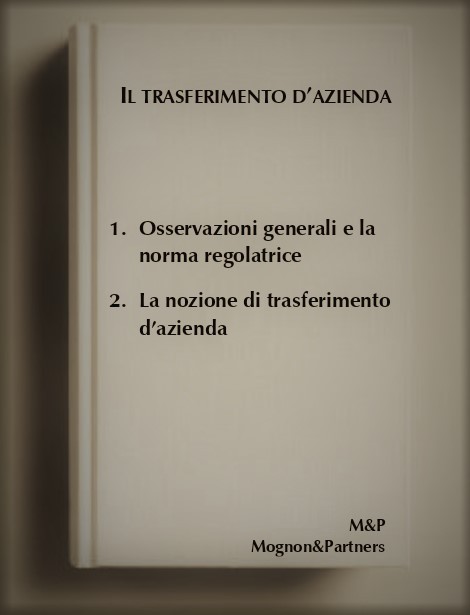
Il trasferimento di azienda
Nell’ambito di questi nostri periodici incontri, divenuti ormai una
prassi, desideriamo condividere, in una serie di 6 articoli suddivisi in 13
argomenti, alcune considerazioni e riflessioni su di un tema che riveste sempre
un particolare interesse:
il trasferimento d’azienda
Come d’uso, cercheremo di “ancorare” tali riflessioni alle più recenti
pronunce della Giurisprudenza in materia, ma, stante l’ampiezza del tema, si
impone la trattazione per capitoli.
Indice
1.
Osservazioni generali e la norma
regolatrice
2.
La nozione di trasferimento d’azienda
3.
Il titolo del trasferimento
4.
Casistica
5.
Il trasferimento di parte dell’azienda
6.
Cessione d’azienda e successione
nell’appalto
7.
La procedura di informazione e
consultazione sindacale
8.
La continuazione dei rapporti di lavoro
9.
La conservazione dei diritti
10.
Il contratto collettivo applicabile ai
lavoratori trasferiti
11.
La responsabilità solidale del
cessionario
12.
Il trasferimento di azienda in crisi
13. I termini di impugnazione del trasferimento d’azienda
1. Osservazioni generali a norma regolatrice
Il trasferimento d’azienda è l’atto giuridico con cui si determina la
successione, a titolo particolare (v. cap. 3), del cessionario al cedente nella
titolarità dell’azienda o di parte di essa.
Esso si annovera, quindi, tra le modificazioni soggettive del rapporto
di lavoro.
La fattispecie è espressamente regolata, con riguardo ai rapporti di
lavoro, dall’art. 2112 del Codice Civile.
La norma poggia su due principi cardine: la continuazione dei rapporti
di lavoro e la conservazione dei diritti.
Ed è in forza di tali principi che si ritengono pacificamente
inapplicabili ai rapporti di lavoro, in caso di trasferimento d’azienda, le
disposizioni di cui agli artt. 1406 e 2558 del codice civile.
La prima di tali disposizioni regola la cessione del contratto e prevede
il diritto del terzo contraente ceduto (il lavoratore) di esprimere il consenso
alla cessione.
“La cessione d’azienda determina,
con riferimento al lavoratore, la successione legale nel contratto di lavoro, con
conseguente esclusione, ai fini del perfezionamento del contratto di cessione,
del consenso del lavoratore ceduto, che potrà successivamente esercitare il
proprio diritto di recesso nei termini sanciti dal comma 4 dell’art. 2112 c.c.”
(Cass. Sez. Lav. 19 gennaio 2018 n.1382).
La seconda, disciplina la successione nei contratti in caso di
trasferimento dell’azienda ed è appunto ritenuta del tutto inapplicabile al
rapporto di lavoro, essendo la norma di cui all’art. 2112 c.c. ritenuta norma
speciale, ovvero norma che detta una disciplina completamente autonoma.
§
2.
La nozione di trasferimento d’azienda
E’ interessante sottolineare come la disciplina comunitaria (e le
relative pronunce della Corte di Giustizia) abbiano apportato nuovi e rilevanti
concetti per l’identificazione della fattispecie del trasferimento di azienda.
In particolare, la Corte di Giustizia ha stabilito che, per applicare le
garanzie della Direttiva n. 23 del 2001 (sul trasferimento d’azienda) è
necessario che “oggetto del trasferimento” sia l’ “entità economica organizzata, intesa quale complesso di persone ed
elementi – patrimoniali e non patrimoniali – i quali consentano l’esercizio di
una attività economica finalizzata al perseguimento di un determinato obiettivo”
(Corte di Giustizia CE 2.12.1990; Corte di Giustizia CE 10.12.1998).
In attuazione della Direttiva Comunitaria il legislatore italiano ha
modificato il testo dell’art. 2112 cod. civ., con il D. Lgs. n. 276/2003,
laddove si precisa che la disciplina ivi contenuta si applica quando oggetto
del trasferimento sia una “attività economica organizzata”.
Leggesi, infatti, nel testo in vigore dell’art. 2112 c.c., V° comma,
che:
“Ai fini e per gli effetti di cui
al presente articolo si intende per trasferimento d’azienda qualsiasi operazione
che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella
titolarità di una attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro,
preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria
identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base
del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l’usufrutto o l’affitto di azienda.
Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì al trasferimento di
parte dell’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di una
attività economica organizzata, identificata come tale dal cedente e dal
cessionario al momento del suo trasferimento”.
La Corte di Cassazione ha quindi precisato che
“Per ramo d’azienda ai sensi
dell’art. 2112 cod. civ. deve intendersi ogni entità economica organizzata in
maniera stabile, la quale, in occasione del trasferimento, conservi la sua
identità, il che presuppone, comunque, una preesistente entità produttiva
funzionalmente autonoma (potendo conservarsi solo qualcosa che già esiste) e
non anche una struttura produttiva creata ‘ad hoc’ in occasione del
trasferimento o come tale unicamente identificata dalle parti del negozio
traslativo, dovendosi ritenere preclusa l’esternalizzazione come forma incontrollata
di espulsione di frazioni non coordinate fra loro, di semplici reparti o uffici
ovvero di articolazioni non autonome” (Cass. Sez. Lav., 30 gennaio 2018, n.
2280).
Ed ancora:
“In materia di trasferimento
d’azienda o di parte (c.d. ramo) di essa, tanto la normativa comunitaria
(direttive CE nn. 98/50 e 2001/23) quanto la legislazione nazionale (art. 2112,
comma quinto, cod. civ., sostituito dall’art. 32 del d. lgs. 10 settembre 2003
n. 276) perseguono il fine di evitare che il trasferimento si trasformi in
semplice strumento di sostituzione del datore di lavoro, in una pluralità di
rapporti individuali, con altro sul quale i lavoratori possano riporre minore
affidamento sul piano sia della solvibilità sia dell’attitudine a proseguire
con continuità l’attività produttiva, osservando che la citata direttiva del
1998 richiede, pertanto, che il ramo d’azienda oggetto del trasferimento
costituisca un’entità economica con propria identità, intesa come insieme di
mezzi organizzati per un’attività economica, essenziale o accessoria, e,
analogamente, l’art. 2112, comma quinto, cod. civ. si riferisce alla “parte
d’azienda, intesa come articolazione funzionalmente autonoma di un’attività
economica organizzata”.
(Cass. Sez. Lav. 5 giugno 2018, n. 14390).
Per finire con una nozione di ramo d’azienda ‘dematerializzato’:
“E’ legittima la cessione, come
ramo d’azienda, di una struttura dematerializzata costituita prevalentemente da
rapporti di lavoro organizzati in modo idoneo, anche potenzialmente, allo
svolgimento di una attività economica, a condizione che i lavoratori ceduti
costituiscano un gruppo coeso per professionalità, con precisi legami
organizzativi preesistenti alla cessione e specifico know-how tali da
individuarli come una struttura unitaria funzionalmente idonea e non come mera
sommatoria di dipendenti.
Incombe sul datore di lavoro che
intende avvalersi degli effetti previsti dall’art. 2112 c.c. fornire la prova
che i lavoratori ceduti facessero parte del ramo ceduto”.
(Cass. Sez. Lav. 28 agosto 2018, n. 21264).
Risulta così superato il tradizionale concetto di azienda di cui all’art. 2555 c.c. (complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa) e si va più verso la definizione di imprenditore di cui all’art. 2082 c.c. (chi esercita professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o lo scambio di beni o di servizi).
Paolo Ferraresi




